La violenza in carcere sui detenuti, un circolo vizioso da spezzare
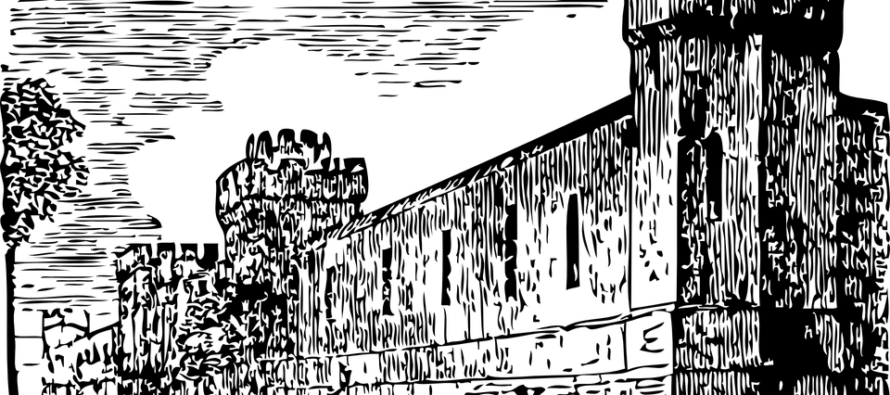
![]()
Stupirsi della violenza significa fare il gioco del fascismo, scriveva Walter Benjamin. La violenza è parte costitutiva dei rapporti di potere presenti nella società. La violenza è il cuore del diritto penale e della risposta punitiva dello Stato. È questa una violenza regolamentata, strutturata, limitata. La passione per le punizioni, che ha tragicamente permeato di sé il mondo contemporaneo, richiede però un tasso di violenza ulteriore, una violenza “illegale”, “arbitraria”, “rapsodica”. In momenti storici e politici come quello attuale, quando si sentono ministri evocare espressioni quali «marcire in galera» oppure ammiccare a coloro che bendano e legano un indagato durante un interrogatorio, quell’uso e abuso di una violenza “illegale”, “arbitraria” e “rapsodica” viene percepito come parte della pena stessa, nella certezza interiore dell’impunità e del giudizio comprensivo, se non addirittura benevolo, dei cattivi maestri al potere. D’altronde basta leggere alcuni siti informativi di polizia o le loro pagine social per capire di cosa stiamo parlando: i detenuti sono chiamati bastardi o nella migliore dell’ipotesi camosci, riproponendo uno slang carcerario antico, offensivo e violento.
SUBIRE VIOLENZA in carcere da parte degli agenti di polizia penitenziaria è un’esperienza drammatica. Di solito non è mai una violenza isolata. È molto più spesso una violenza ripetuta. Il detenuto che non si sa fare la galera, espressione che indica quella persona che in qualche modo obietta o si contrappone alle regole di vita interna, o il detenuto che è per suo status considerato un inferiore, ad esempio una persona accusata di reati sessuali, un collaboratore di giustizia, ma di questi tempi anche un detenuto africano, vive in una condizione di paura e di soggezione. L’uso della violenza è spesso di gruppo. Anche quando è uno solo l’agente che pratica la violenza, gli altri stanno lì a guardare, come i pali in una rapina in banca. È una violenza che avviene di solito nei reparti più isolati, al riparo da sguardi disposti a raccontare quanto visto, con lo scopo di dare una lezione, sicuri di far bene e di farla franca.
Il detenuto di solito ha paura, vive nel terrore, non denuncia, essendo forte il rischio di vendette ulteriori. Per rompere il circolo vizioso della violenza è necessaria una rivoluzione culturale che comprenda una sana alleanza tra le istituzioni, il recupero della fiducia da parte di ciascun attore del sistema penitenziario, ivi compresi i detenuti, indagini rapide, meccanismi di prevenzione funzionanti.
NEI GIORNI SCORSI sarebbe accaduto un episodio di pestaggi in un reparto di isolamento. Ecco la novità. Si è costruita una santa alleanza che ha interrotto quel circolo vizioso mentre era drammaticamente in corso ed è stata aperta la strada alla sottoposizione a processo dei responsabili di quella violenza. Il ruolo vigile e rigoroso dell’autorità garante nazionale dei diritti delle persone detenute, la pressione di Antigone, la straordinaria collaborazione di alcuni dirigenti penitenziari hanno prodotto l’interruzione del ciclo di pestaggi. Non sappiamo se ci sarà una condanna per tortura o per altro delitto. È troppo presto e troppi pochi sono i dettagli che per ora si conoscono. Ma la storia insegna almeno due cose: la violenza “illegale”, “arbitraria”, “rapsodica”, anche se non può essere del tutto spazzata via, può comunque essere efficacemente contrastata anche dall’interno delle istituzioni; una significativa parte degli operatori penitenziari ha una cultura democratica così radicata che non è comprimibile da un qualsiasi cattivo maestro. A loro siamo grati.
VISITARE UN CARCERE, così come fanno i radicali in queste ore, ha anche questo doppio scopo: da un lato toglierlo da quel cono d’ombra che inevitabilmente produce isolamento e, dunque, violenza; dall’altro dare dignità a quel mondo penitenziario che da sud a nord resiste alle tentazioni di liquidazione di una storia democratica della pena. Al sud, al centro e al nord ci sono dirigenti, direttori, poliziotti, educatori straordinari. Meriterebbero una ben più rilevante gratificazione sociale, economica e professionale.
Nei giorni scorsi abbiamo visitato il carcere napoletano di Secondigliano. Qualche tempo prima quello di Bari. In tutte e due gli istituti, nel sud intriso di problemi anche criminali, abbiamo trovato operatori in divisa e non che con entusiasmo e fatica cercano di dare esecuzione alle norme costituzionali che prevedono che la pena non debba consistere in trattamenti contrari al senso di umanità. Le norme sono importanti, le riforme pure, ma più di tutto conta la cultura democratica e antropocentrica di chi deve gestire corpi e anime.
*Presidente di Antigone
Fonte: Patrizio Gonnella, IL MANIFESTO
Related Articles
Le carceri “liberalizzate”
![]()
Liberalizziamo le carceri? Affascinante l’ossimoro proposto dal decreto Monti. Ma non si tratta di aprire porte e finestre e di consentire, a chi vuole, di uscirne e, magari, a qualcuno di entrarci di propria sponte.
L’inferno dei ragazzi dell’Irar
![]()
Viaggio nel carcere minorile di Rosario, Argentina, dove i giovani detenuti subiscono quotidianamente vessazioni e vivono in condizioni igieniche precarie.
Londra, niente mutua per obesi e fumatori
![]()
La misura, presentata come un nuovo approccio medico, è dettata dalle crescenti difficoltà per le casse della sanità pubblica (la



