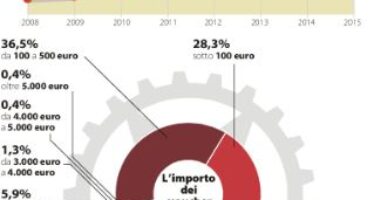Nel saggio Noi figli di Eichmann, pubblicato in piena guerra fredda, il filosofo Günther Anders ha preso in esame la questione dell’empatia. «Non esiste un essere umano capace di rappresentare a se stesso un evento di portata orribile quanto l’eliminazione di milioni di persone», scrive. Si riferisce a Hiroshima e Nagasaki riflettendo, in altri termini, sulle conseguenze etiche e umane della guerra fredda: il sistema di terrore che ha preceduto quello che stiamo subendo oggi. Oltre un certo limite – è questa la sua tesi centrale – la nostra capacità di fare supera la nostra capacità di immaginare ciò che facciamo. Superata tale soglia l’empatia viene meno: «Il troppo grande ci lascia freddi ». Un concetto che Hanna Arendt aveva espresso nel saggio sulla banalità del male. Incapace di rappresentare a se stesso la portata di ciò che aveva compiuto ad Auschwitz, vi si legge, Eichmann ha limitato il suo universo mentale all’esecuzione meccanica ed amministrativa dei propri compiti. Tutti i sopravvissuti del Bataclan, ad esempio, hanno testimoniato di come gli assassini abbiano eseguito il proprio compito “come dei robot”, senza fretta, senza passione, senza odio apparente. Le vittime degli attentati ciechi sono, per definizione, vittime del caso. È per questo che di fronte a un evento simile proviamo la forte tentazione di attribuire ad esso una logica. Le “spiegazioni” hanno lo scopo di limitare un’empatia che altrimenti risulterebbe intollerabile. Tuttavia la portata degli attentati del 13 novembre è tale da impedire questa presa di distanza. Come già accaduto dopo l’11 settembre, i media hanno quindi stilato degli elenchi parziali delle vittime nei quali la chiave dell’empatia era affidata al mimetismo: «hanno colpito persone a caso, anche persone che qui non menzioniamo, e avrebbero potuto colpire voi». Un simile mimetismo non è però meno ambiguo. Dopo tutto, se a chiunque può accadere qualsiasi cosa, come si può evitare che ciascuno di noi altro non sia che una vittima? «Il troppo grande», scrive Anders, «ci lascia freddi».
Questa trappola della ragione narrativa a cui i media, presi dall’immediatezza degli eventi, non riescono a sottrarsi, è uno degli effetti perversi a cui il terrore punta. Perché il terrore è una guerra di rappresentazione. Don DeLillo fa dire a un personaggio del romanzo Mao II: «Ciò che i terroristi guadagnano gli scrittori lo perdono ». «Beckett è l’ultimo scrittore ad aver forgiato il nostro modo di vedere e di pensare. Dopo di lui, l’opera principale comporta esplosioni a cielo aperto e il crollo di edifici. È questa la nuova narrazione tragica».
© Le Monde 2015 ( Traduzione di Marzia Porta