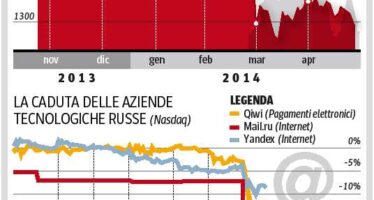F., 19 anni. «Mi hanno presa a Shingal il 3 agosto, domenica. Sono scappata e mi hanno ripresa. Ci hanno separati, uomini da donne. Ci hanno portate a Tell Afar, e dopo 5 giorni a Mosul. Ero reclusa in una casa di tre piani, sono riuscita a forzare la porta e rifugiarmi da vicini, ma un guardiano mi ha trovata: sono stata legata e senza cibo e acqua per 4 giorni. Il mio violentatore mi ha portato a casa sua, a servire le sue donne. Due mesi: una sera ho detto che andavo a lavarmi le mani prima di cena, ho preso un niqab e sono scappata. Ho bussato, alla seconda casa mi hanno lasciata entrare. Ci sono restata una settimana, finché mio zio ha combinato la fuga a Kirkuk. Nella mia famiglia eravamo 14, io sola sono scappata».
D. ha 19 anni, viene dal villaggio di Kocho. «Il 16 agosto ci radunarono a mezzanotte nella scuola, pretesero denaro e gioielli, promisero di lasciarci andare. Gli demmo tutto, e ci separarono fra gli uomini, sotto, e le donne al piano superiore. Dissero che dovevamo convertirci: nessuno cedette. Portarono via gli uomini in camion, a morire. ha fatto il morto, è stato l’unico sopravvissuto al massacro di Kocho. Mia madre è maltrattata ma è viva a Tell Afar. Del resto della famiglia non so».
O. ha 12 anni, e sembra ancora più piccola. Non ha mai voluto parlare, ma oggi, dicono, è pronta. Guarda fisso davanti a sé, sotto le ali delle compagne. «Avevo finito la scuola primaria, a Mosul. Ci hanno portate nel villaggio di Rambusi, poi a Raqqa. Uno di loro mi disse che mi avrebbe portato a vedere mia madre, e lo fece: restai con lei una notte, poi mi riportò via, e mi chiuse in una casa vuota. Un’ora dopo sono scappata, una famiglia siriana mi ha tenuta una notte ma avevano paura, mi passarono a Portarono noi in una scuola di Solah, ci separarono dalle sposate e ci trasportarono a Mosul, in tre autobus. Il giorno dopo ci hanno portate, in 46, a Raqqa: siamo rimaste 10 giorni, e ne sono arrivate altre. Io e J. (ha 24 anni, le sta seduta accanto) abbiamo detto che eravamo sorelle. Ci hanno chiuse in una casa deserta con altre due ragazze. Lei si è tagliata le vene. L’hanno portata in ospedale, c’è stata 5 giorni. Poi ci hanno portate in un altro edificio, 6 ragazze. Ci hanno picchiate per 10 giorni. Siccome abbiamo provato a scappare, mi hanno separata da J., ci hanno picchiate più forte perché non eravamo docili, ci hanno tenute altri 10 giorni a Deir ez-Zor, mi sono ferita al viso e gravemente a una gamba. Ho tentato di uccidermi 7 volte. Hanno colpito con un bastone J. a un occhio, continuava a sanguinare. Ci hanno spostate, vicino a un benzinaio. C’era una ventina di caravan, due per noi ragazze. Abbiamo rubato un telefono e chiamato i parenti in Germania, ma era difficile, finché scoppiò uno scontro fra l’Is e gente tribale, e siamo scappate, in sei. Ci siamo nascoste in un villaggio abbandonato per tre giorni, poi da una famiglia siriana, per altri tre, finché è venuta un’auto a prenderci. Avevano chiesto 40 mila dollari, poi ci hanno date per 30. Sono arrivata il 17 dicembre».
J.: «Mio fratello era ferito ma un’altra famiglia, poi col numero di mio zio — mia madre me l’aveva segnato — riuscirono a riscattarmi. Sono l’unica scampata del mio gruppo. Sto con lo zio a Zakho». Le chiedo, delicatamente quanto so, come mai il suo carceriere l’avesse portata da sua madre. «Gliel’avevo chiesto», dice, indifferente. «Era un uomo sulla cinquantina».
Succedeva che dessero segni di umanità? Non sembrano crederlo. «Una ragazza era malata di cancro — dice una — e l’hanno portata dal medico». Come mai riuscivate a usare i telefonini? A volte i guardiani si dimenticavano d’essere cattivi, altre volte le facevano telefonare per schernire i parenti. A volte lasciavano i telefoni in carica e loro li usavano.
R., 21, dice: «Si concentravano su quelle dai 10 ai 15 anni, le più vulnerabili dal lavaggio del cervello. Una era con me, Jilan, aveva tredici anni, si è suicidata dopo che l’avevano toccata sulla testa: hanno buttato via il corpo, come spazzatura. Chiedemmo di pregare, ce l’hanno vietato. Il giorno prima avevano ucciso suo padre. È successo il 14 agosto, a Baaj». Come si è uccisa? «È andata in bagno, si è tagliata i polsi e la gola con il coperchio del suo beauty case. Il sangue scorreva sotto la porta».
Mentre una alla volta raccontano, una esce vacillando, la quattordicenne N., sorretta da una compagna. «Prova continuamente a impiccarsi», dicono.
R. dice che con lei c’erano 3 bambine dodicenni, e anche una di 9 mesi orfana, in braccio a una zia. «Ne ho viste di 4, 5 anni, tante ». G., 18 anni: «Nella mia famiglia eravamo 20, siamo 3. A Kocho su 1200 uomini sono vivi in 200. Le nostre famiglie sono ancora sequestrate, là un giorno dura un anno. Vorremmo tornare a casa, ma siamo state violentate e spogliate di tutto dai nostri vicini arabi. Dobbiamo avere una distanza di sicurezza».
N., che era rientrata, e si era seduta vicino alla porta, crolla svenuta, e sembra avere le convulsioni. Non è epilettica, dicono, è incinta e respira male per la gola ferita. Più tardi anche S., 13 anni, sverrà. Fu la prima a scappare. «Non riesce a calmarsi», dicono.
D., 19 anni. Il 3 agosto mi hanno presa, vicino a Lalish. Mi hanno tenuta tre notti a El Baraj, due a Tell Afar, una settimana alla prigione di Badosh, 10 giorni a al Bahaj, poi 5 notti nel complesso di Khatania, poi a Kocho: sono riuscita a usare un cellulare e ho chiamato mio fratello. Ero con altre tre, noi stavamo al piano di sopra, cucinavamo per loro, e una notte siamo scappate. Un uomo ci ha portate al monte Shingal, abbiamo camminato ore verso la cima, finché ci ha raccolte un elicottero.
Tremo quando uno dei tutori le fa la domanda più impossibile: «Che cosa ti aspetti dal futuro?». Lei però riflette davvero, poi dice calma: «Mi aspetto di tornare e ucciderli tutti. Piuttosto che salvare me dovevo ucciderne uno di loro». Allora riprendono la parola le due amiche che avevano parlato per prime. «Un giorno che il nostro carceriere si era addormentato, gli abbiamo preso il kalashnikov. E poi non abbiamo avuto il coraggio di sparare». Non chiedo se se ne rallegrino, o rimpiangano di non aver avuto quel coraggio. Forse non hanno ancora deciso. Solo dopo, quando la riunione si scioglie e si va a mensa e a farsi fotografie per ricordo, mi indicano sottovoce una di loro, S., che è restata in silenzio. «Lei l’ha ucciso il suo stupratore, per riuscire a scappare ». Lo dicono con un rispetto e una tenerezza speciale.