Postumano Oltre la gabbia del soggetto
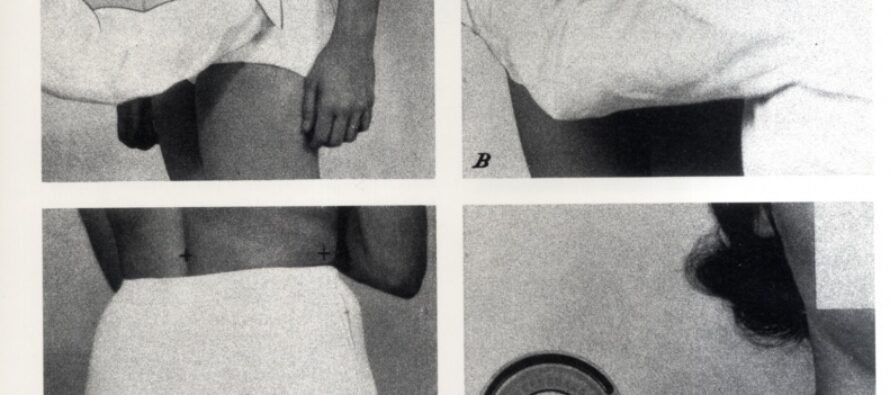
![]()
Negli scorsi giorni la filosofa Rosi Braidotti, che ad Utrecht dirige il Centre for the Humanities, è stata in Italia (Bologna, Napoli e Roma) per la presentazione del suo ultimo volume, Il Postumano – La vita oltre l’individuo, oltre la specie, oltre la morte (recensito qui il 18 febbraio 2014). Il postumano è un tema con cui Braidotti si misura fin dai tempi di Soggetti nomadi (1994) dove viene nominato come progetto utopico e politico con cui fare i conti. In questi anni, all’interno di un dibattito internazionale vivacissimo che l’ha vista al centro di numerosi confronti, ha proseguito la sua riflessione sulla soggettività chiarendo ora come il posizionamento postumano, bussola e strumento genealogico, preveda anzitutto un nomadismo acquisito sia sotto il profilo della teoria materialista del divenire che sotto il profilo etico-politico. Su questo punto, le categorie che intervengono sono in effetti quelle che negli anni le hanno consentito di tracciare una mappatura all’altezza dei tempi presenti. Sono, questi ultimi, anche tempi pensanti e di particolare potenza, in cui le pratiche politiche e di resistenza giocano il proprio corpo a corpo con una molteplicità di risorse e conflitti. Anche qui la partita giocata da Braidotti muove da una collocazione esatta: femminista, postcoloniale e radicalmente responsabile. Attraverso la lezione di Foucault, Irigaray, Deleuze e Guattari dirimente è la forza propulsiva del monismo spinoziano e l’apertura alla critica femminista contemporanea. In questo crocicchio, le tessere del presente si spostano e si intersecano verso la ridefinizione di umano e disumano. Fino al salto definitivo.
Alcuni temi ritornano in maniera decisiva facendo della architettura filosofica in divenire di Braidotti una cartografia trasformativa delle idee. Tale trasformazione, che avviene conseguentemente alla crisi dell’umano, mostra le trappole ma pure le risorse di una contemporaneità tutta ancora da agire.
Uno dei paradossi più evidenti della nostra era è, secondo te, lo scontro tra la necessità stringente di affidarsi a nuove azioni etico-politiche e l’inerzia di chi vorrebbe curare esclusivamente i propri interessi e profitti. A cagione di questa ultima posizione si propone infatti un generico appello al nuovo che risuona come puro esercizio retorico in relazione alle logiche di mantenimento del potere e individualismo neoliberale. In questo senso intercetti quella che chiami forza tecnologica liberatrice e trasgressiva, prestando attenzione all’appropriazione da parte di chi vorrebbe inserirle in un discorso tradizionale e conservatore del soggetto (perlopiù autocentrato, bianco, maschio, eterosessuale e benestante). Mi dici qualcosa a riguardo?
La retorica del nuovo fa parte del programma di consumismo sfrenato e maniacale del capitalismo avanzato. C’è una tensione tra il potenziale gigantesco delle nuove tecnologie che hanno come meta il controllo del vivente e di tutte le sue forme, e l’uso monodirezionale che ne viene fatto dal capitalismo — per cui il capitale è la vita stessa. E soprattutto il fatto che hanno riallacciato questa molteplicità complessa alla nozione più restrittiva possibile di individualismo, associandoci una morale molto stanca, la classica morale neokantiana umanistica, che sta andando alla grande. Viviamo in un’epoca moralizzatrice, cruenta e contraddittoria. Quindi io non voglio cadere nel discorso antiquato della tecnofobia che prevede la tecnologia come strumento di dominio perché non ci credo; sono stata allieva di Foucault e il potere non è mai a senso unico. Queste tecnologie sono al tempo stesso liberatorie e strumenti di morte e di distruzione. Abbiamo droni, telefonini, fecondazione assistita e poi i morti al largo di Lampedusa; sono versanti della stessa medaglia e noi dobbiamo pensare alla contemporaneità e agli effetti del potere, molteplici e contraddittori. La forza liberatrice della tecnologia è, e dev’essere, fonte di esperimenti. Sperimentare alcune di queste tecnologie, nei limiti del possibile, sarebbe per me una specie di ridefinizione di ciò che la filosofia dovrebbe fare. Ci occorrono laboratori fondamentali con i quali ricostituire comunità di sapere ma anche di saper fare a partire da queste tecnologie. Inoltre non sono contraria a priori alle modificazioni genetiche. Penso per esempio alla biologia sintetica che è riuscita a fare le prime porzioni di carne artificiale. Si metterebbe in discussione l’obiezione morale di vegani e vegetariani, visto infatti che non è carne da macello di organismi viventi. C’è poi un laboratorio molto forte e bello riguardo i disabilities studies che stanno andando in direzioni molto più interessanti rispetto ad esempio agli studi sulla sessualità in generale, proprio perché i corpi sono già modificati.
Tra le trappole dell’appropriazione neoliberale della tecnologia, c’è una piega che concerne ciò che in Trasposizioni (2006) chiami tecno-utopismo dell’ambiente accademico. Cosa intendi con questa forma di mistificazione?
Negli anni Novanta, alla fine dell’ondata dei cultural studies e più o meno all’inizio della svolta queer, c’è stato un momento di grande euforia verso le tecnologie. Le tecno-utopie sono state da una parte importanti perché ci hanno permesso di combattere quel disfattismo tecnofobico che per me fa sempre parte di una certa cultura di sinistra seguendo il ragionamento tecnologia=potere=proprietà di qualcuno=lotta di classe; equivalenze che fanno parte della mia giovinezza; sono una donna di sinistra, vengo dal femminismo e so, insieme a Foucault, che il potere è sempre più complicato di questo. Ci sono altre modalità di pensiero per le quali fondamentale è il manifesto del 1985 di Donna Haraway. Il manifesto cyborg che nella versione originale è sottotitolato come manifesto socialista e femminista, completamente svanito nella nuova edizione. Trovo invece che sia molto importante ripensarlo perché era un socialismo come possibilità di comunità a venire. Ci è voluto qualche annetto per capire la mutazione del capitalismo in un sistema di ri-formazione e ri-creazione del vivente. Nel politico siamo nella confusione più totale; da una parte il capitalismo si è dato una pratica post-antropocentrica, ha equiparato tutte le specie, tutte le forme viventi, alla logica del profitto. Se tu guardi la robotica per esempio, non stiamo clonando solo il sistema neuronale e sensoriale dell’umano ma anche il fiuto dei cani, il radar e il sonar di delfini e pipistrelli. Cioè il nostro corpo è un apparato piuttosto antiquato rispetto ad altre specie animali. Quindi c’è un postumano di fatto, però nel discorso pubblico siamo ancora ad una forma di conservatorismo neoumanista, con una moralizzazione terrificante e forme di reazione assolutamente inquietanti. Invece di tecno-utopie ci sono da fare delle mappature, delle cartografie critiche di queste contraddizioni. Per evitare anche di ripetere una morale stanca che da Nietzsche in poi abbiamo criticato in filosofia. Anche con la faccia sorridente di papa Francesco e quella — meno piacevole — di Renzi, non si può tornare a pratiche di una vita definita sotto l’egemonia dell’umanesimo in un’epoca in cui il capitalismo ci ha dato un post-antropocentrismo perverso; non è giusto, questa è una beffa molto crudele che rischiamo di pagare caro. Quindi dobbiamo riferirci ad un’etica postumana, questa è la mia linea. Non possiamo pensare ai droni, ai computer che fanno i calcoli in borsa nella cornice della morale kantiana, dobbiamo cominciare a inserire nel loro programma domande di natura etica in grado di farli perdere in velocità ed efficacia, di non farli funzionare più. Quando i droni israeliani sparano nei territori occupati non stanno ad aspettare o a interrogarsi. Quando Google-earth deve cancellare dalle sue foto satellitari le corse dei droni, che sono centinaia, i test morali risultano inutili. Quindi piantiamola con questa faccenda; bisogna rallentare tutto e cambiare il verso di queste tecnologie, sperimentare un’altra etica. Ma questa combinazione di post-antropocentrismo capitalista e neoumanesimo sociale è una catastrofe. Ci risucchia energie e funziona: questa morale la capiscono tutti; tipo quella della cura; dunque “abbi cura”, poi però quelle che devono aver cura sono sempre le donne.
Questo tema della cura mi interessa, perché come altre credo che il femminismo ne abbia scalzato il carattere oblativo. Ne Il Postumano, quando poni la relazione tra l’eccedenza di zoe e la consapevolezza femminista, dici infatti “io sono la madre terra, generatrice di futuro”. Chiaro come ciò inerisca al carattere della temporalità ma anche dell’aver cura.
Il posizionamento femminista nel libro ha molti piani perché ha vari obiettivi. Uno di questi è costruire delle cartografie ragionate attraverso cui comprendere come siamo arrivati a questo scavalcamento dell’umano. Un altro obiettivo è quello di portare la questione della differenza nel postumano. Il terzo è quello spinozista-monista di sperimentare nuove etiche, nuove comunità, nuove cosmologie; cioè pensare, essendo stata allieva di Deleuze, nuove forme per leggere il presente. Il punto di partenza è la critica al soggetto unitario. La teoria del prendersi cura di Gilligan, Tronto e di molti altri resta all’interno di un pensiero liberale nella stragrande maggioranza dei casi. Le temporalità che ci abitano come soggetti sono diffusissime; dalla temporalità cronologica a quella circolare da Nietzsche in poi a quella transpecie fino ad arrivare a temporalità di memorie protesiche. Non possiamo tornare all’uno. Il mio problema con la cura è stato questo. Il pezzo che tu citi io lo chiamo momento di opera rock. Sono momenti abbastanza diffusi nel libro in cui metto in scena il mio pensiero nomade dicendo essenzialmente che io uomo non lo sono mai stata e non ho mai voluto esserlo. Non uno, non lui, non quello, non così. Mai. Io sono della generazione della differenza che è stata una spaccatura dall’umanismo, da quell’uno, uomo, bianco, maschio, eterosessuale da cui hai cominciato giustamente l’intervista. Questo è stato il mio orizzonte. Noi siamo sempre state le lupe che correvano nella notte, ululando giustizia ma anche rabbia, amore, felicità insieme a tutto il resto. Quindi c’è questa parte di me che credo sia non solo generazionale ma proprio concettuale e teorica che non si è mai immedesimata con quell’uno. Ciò non significa che non abbiamo cura dell’altro. Il contenimento dell’altro in un’ottica spinoziana e deleuziana (c’è anche Irigaray ma è un caso più complicato) consiste in una specificazione reciproca. Autogestiamo la nostra specificazione, definiamoci in quanto postumani, collettivamente e uno in rapporto all’altro, una in rapporto alle altre, su momenti di pratica molto precisi. C’è un postumano nella teoria, c’è un postumano nella pratica, c’è un postumano nell’etica, ci sono momenti e praxis concrete e immanenti che ci permettono di autodefinirci.
Molta della tua riflessione si è concentrata verso le scienze umane e una idea specifica di università o, come la chiami, multiversità. Penso al quarto capitolo di Il Postumano. In considerazione degli alti livelli di mediazione tecnologica da un lato e delle strutture del mondo globalizzato dall’altro, auspichi una metamorfosi epistemologica delle scienze umane. Intanto partendo da un assunto che è quello che muove la tua intera riflessione filosofica, e cioè il realismo di una materia capace di affetti, autogestione e autopoiesi. Intercetti dunque la teoria femminista come cruciale punto di riferimento metodologico e teoretico. Anche nelle scienze umane postumane, è ancora una volta il femminismo a fare la differenza?
Assolutamente. Non mi preoccupo del femminismo come movimento politico che sta procedendo molto bene soprattutto grazie alle giovani femministe sparse nel mondo. A livello di pensiero però le metodologie femministe, nonostante l’esistenza di women’s studies e gender studies, non sono passate all’interno delle università. Secondo me la metodologia fondamentale è quel partire da sé, che però io coniugo con la dissoluzione del Sé. Quindi partire da un Sé che non è mai uno ma già una relazione. Un sapere situato è rendere conto del proprio posizionamento e non parlare in maniera universalistica e generale, per non aspirare neppure a quelle mega-teorie del tutto di cui una buona fetta della sinistra è ancora molto innamorata. La teoria della rivoluzione per esempio, del “o cambiamo tutto o non vale la pena di cambiare niente” produce un assolutismo che mi preoccupa molto. Il femminismo è sempre stato molto più pratico e molto più efficace: si cambia il vivente a partire da sé, il personale è politico e le relazioni sono al cuore di tutto. Trovo che il monismo spinoziano si coniughi perfettamente con questa politica situata. C’è in questo momento, a livello di pensiero, una strana cancellazione del femminismo soprattutto da parte dell’università, la quale tuttavia cancella un po’ tutto il Ventesimo secolo ma anche di quello che resta della sinistra. Diciamo dal 1989 in poi, se si guardano autori che i miei studenti (soprattutto maschi) amano, per esempio Žižek, Badiou ma lo stesso Negri, si può notare come questi ultimi abbiano cancellato il femminismo. Non lo citano mai come esempio di un movimento che ha reinventato il politico. Žižek ci va giù pesante, siamo al meglio un piccolo movimento culturale che non ha capito niente; Badiou ancora peggio; un paio di note di Negri in un libro (La differenza italiana, Nottetempo 2005) in cui scrive di Muraro, certo, ma si arrabattano e non riconoscono il femminismo come un laboratorio di pratiche. E questo è un dramma perché lì c’è un dialogo e contaminazioni reciproche che sono saltate. Per finire, c’è anche da dire che la sinistra, in particolare la scuola italiana di studi critici sul capitalismo (per esempio Virno, Lazzarato, Mezzadra), potrebbero osare, sperimentare di più con scienza e corpi. In questo perfino Foucault non è riuscito, il suo maestro Canguilhem era più attento di lui. Noi avremmo molto da dire a riguardo, abbiamo avuto una serie di geni, tra cui spicca Haraway, ma anche la scuola italiana di Gagliasso, che la scienza l’hanno capita benissimo. Insieme a queste ci sono pure molte economiste femministe che sostengono che il capitale è oggi la vita, nient’altro che i codici informativi del vivente; un’affermazione che cambia tutti i giochi. Quindi ci sono come degli anelli mancanti. Mi sembra che in Italia sia un momento in cui si deve riflettere su cosa conta come gesto politico. Il fatto per esempio che il femminismo sia stato rimosso da un movimento politico che poi lamenta che non abbiamo modelli di politica mi rende davvero furiosa. Soprattutto quando si devono ricevere accuse come “voi non avete fatto niente”, in un momento in cui io vedo risorgere una violenza che mi preoccupa molto. Dalla prima pallottola la vostra rivoluzione non ci interessa più. Giravano slogan come questi negli anni ‘70 e qui stiamo tornando a una rabbia nichilista che minimizza sbrigativamente ciò che il femminismo ha prodotto come modello alternativo di politica. Su questo credo che l’Italia abbia qualcosa su cui riflettere. O ci ascoltate o non contate su di noi per fare una rivoluzione antiquata che farà soltanto il gioco delle leggi speciali della repressione e non servirà a niente. Sulla questione del postumano dunque mi sembra che stiamo assistendo, in questo momento di sgomento e rabbia dovuti alla crisi, alla riproposizione dell’antropocentrismo e narcisismo della sinistra. Rimuovere il femminismo apre la porta alla violenza, soprattutto contro le donne, insieme al ritorno di una violenza rivoluzionaria che ha già fallito e che non mi pare il caso di riproporre.
La rabbia che proviamo quando subiamo o assistiamo a un’ingiustizia è una passione che deve permetterci di sostenere il presente, di modificarlo a seconda dei nostri desideri, invece di disperderla in inefficaci atti nichilisti, noi possiamo trasformarla in affetto positivo. Investiamo nella ricerca di alleanze trasversali, di sinergie inedite, elaboriamo saperi comuni lontani dalle logiche del profitto, contaminiamoci e diffondiamo micro-politiche alternative ai modelli dominanti, stili di vita ecosostenibili, antisessesisti e antirazzisti.
Non voglio più eroi morti.
Related Articles
Unione dei popoli europei. La lezione di Mandela
![]()
L’UNIONE dei popoli europei è sorta come reazione alle guerre che hanno devastato il continente nel XX secolo, o alla minaccia di un regime tirannico
I predicatori della virtù
![]()
ECONOMIE ARBITRARIE
Interiorizzazione di una colpa, organizzazione della propria vita in termini di restituzione infinita di ciò che si è ricevuto: il risparmiatore e il salariato si fronteggiano e si combattono all’interno della medesima persona, sempre dominati dall’alto. Nel libro «Governo dell’uomo indebitato» di Maurizio Lazzarato





