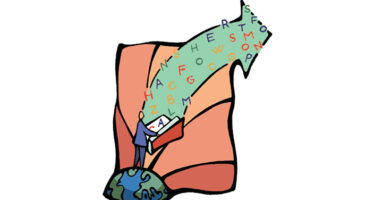Il pugno di Erdogan

![]()
MARCO ANSALDO, la Repubblica
SAGLAM Irade”. Volontà d’acciaio. Il cartellone con la scritta minacciosa, sormontata dalle occhiaie profonde e lo sguardo fermo di Tayyip Erdogan, spunta ovunque a Istanbul. Come un Grande fratello, insegue il visitatore sulla strada fra il moderno aeroporto Ataturk e l’antica Moschea blu. Riempie facciate vuote di palazzi. Corre lungo i parchi che costeggiano lo Stretto del Bosforo. Compare sui bus che solcano il ponte dei pescatori sotto la Torre di Galata.
È un senso di claustrofobia che prende i turchi alla gola. Il primo ministro islamico incombe dappertutto: sugli alberi difesi a stento dalla rivolta di Gezi Park, in ogni (blando) notiziario alla tv, persino dietro la preghiera del muezzin. I cittadini laici, gente di spirito che ancora ieri sulla piazza di Kadikoy spargevano soldi falsi presi a manciate da casseforti di cartone, hanno imbrattato la scritta con disegni di animali e slogan ingegnosi: “Corruttore d’acciaio”. “Fascista di metallo”. “Nemico di ferro”.
Il pugno di Erdogan soffoca la Turchia. Subissato da critiche impietose che lo paragonano a un dittatore o a un despota, il premier che guida il Paese da 12 anni con il 50 percento dei voti, soprattutto anatolici, nelle ultime settimane ha piazzato una legge bavaglio dietro l’altra, al ritmo di una ogni tre giorni. Prima un provvedimento contro la libera navigazione su Internet. Poi una bozza per limitare l’indipendenza della magistratura. Quindi una norma che dà poteri speciali ai servizi segreti del Mit, l’intelligence turca, adesso posta sotto il suo diretto controllo. Assieme al record di cronisti finiti in carcere, se non licenziati o costretti a cambiare giornale, e alle richieste fatte a Google di rimuovere 12mila voci, la Turchia è diventata il Paese al mondo con più giornalisti in prigione (più di Iran e Cina), e il numero uno nel controllare il celebre motore di ricerca. Dati imbarazzanti per un candidato all’ingresso in Europa che si proclama democratico.
Eppure, a dispetto dei bavagli, le notizie filtrano ugualmente. Ad esempio dagli odiati social network, quasi gli unici qui a dar conto di quel che davvero succede. Quando l’altra notte 4 milioni di visitatori hanno ascoltato con sconcerto su Youtub e le
intercettazioni — contestate da Erdogan come «un montaggio» — in cui il premier intimava al figlio di sbarazzarsi da
casa di enormi quantità di danaro, e la gente si riversava in strada in 11 città diverse, alla tv non si trovava riscontro di quel che scriveva l’agenzia di stampa Reuters (altro media vituperato). «Qui ci sono solo show e documentari», diceva adirato un imprenditore straniero cliccando vanamente sul telecomando. Nella cappa plumbea dei media tradizionali era allora necessario collegarsi su Twitter per assistere, in tempo reale, agli scontri di piazza e ai gas lacrimogeni lanciati dalla polizia.
Ma il volto duro del leader turco, contro il quale già lo scorso giugno si erano levati «gli uomini in piedi» nella silenziosa protesta a Piazza Taksim, in quella che resta una delle più belle affermazioni di dissenso mai viste contro un potere, rivela una crepa. Appena un anno or sono, la sua Turchia era sinonimo di stabilità. Persino i laici ai quali Erdogan non è mai piaciuto per l’islamismo sempre meno tenuto a freno, dovevano ammettere l’industriosità dei calvinisti pii venuti dall’Anatolia, e l’innegabile sviluppo economico del primo decennio del Duemila. Il resto era conseguente: l’aggancio al sogno europeo, l’esposizione della Turchia nel mondo, il declassamento politico dei militari un tempo golpisti. Soprattutto l’ultimo punto, la caduta dei generali, era arrivato grazie all’alleanza scaturita con il movimento anch’esso islamico di Fetullah Gulen, predicatore autoesiliatosi in Pennsylvania, influentissimo per le 2000 scuole fondate in 160 Paesi. E mentre il Partito della giustizia e dello sviluppo di Erdogan costruiva scuole e ospedali sotto lo sguardo compiaciuto del potente vegliardo, l’organizzazione misteriosa contribuiva a mandare a processo stormi di ufficiali.
In una Turchia liberata dal secolare controllo militare, la compagine di Erdogan, innalzata a sicuramente democratica dalla macchina mediatica di Fetullah, si dedicava a progetti edilizi faraonici, non esenti da copiose tangenti: un terzo ponte sul Bosforo, un secondo Stretto, una serie di costruzioni mirabolanti ad ovest e ad est del Paese. Quando poi il delirio del mattone aggredì la piazza centrale di Istanbul, Taksim, con l’annunciato taglio dei 600 alberi di noce del Gezi Park, seguito dall’abbattimento della vicina caserma ottomana, il popolo reagì in modo sorprendente. Per strada scesero non solo gli ambientalisti e i comunisti. Ma studenti e impiegati di ogni credo e colore politico, operai e donne con la fionda, persino gente col velo, rimasta stupita dall’arroganza di un leader autoproclamatosi onnipotente. I 19 lunghi giorni di resistenza ai cannoni ad acqua e alle pallottole di gomma della polizia finirono in un massacro, a Istanbul e in tutte le città del Paese, con Erdogan che accusava di complotto gli Stati Uniti e l’Europa, i colossi finanziari e il giornalismo d’inchiesta dei nuovi media.
La sua temporanea vittoria sul campo fu però l’inizio di una battaglia tutta interna all’Islam, che adesso rischia di metterlo in scacco. Già a Fetullah non era piaciuto l’approccio con cui aveva represso la genuina e pacifica protesta popolare. Quando poi a novembre, per tutta risposta, il premier decise di colpire le scuole private del movimento, tagliando i fondi multimilionari a un organismo votato all’istruzione per diffondersi capillarmente, la vendetta di Gulen si abbattè durissima.
I giudici e i poliziotti che a lui si richiamano avviarono un’operazione anticorruzione che svelò al mondo le malefatte del governo turco. Si scoprirono casse di lingotti d’oro e mazzette di danaro nelle scatole da scarpe. Tre figli di ministri di primissimo piano vennero arrestati. Dieci responsabili di dicastero furono costretti al rimpasto. E le intercettazioni telefoniche che ora circolano in rete puntano dritte sul primo ministro, registrato mentre ordina al figlio minore Bilal di nascondere le montagne di soldi accumulate, e ai direttori di giornale di cancellare le notizie scomode. La gente segue attonita. Schiumando rabbia, Erdogan si scaglia contro la presenza di uno «stato parallelo», e opera
purghe di poliziotti, trasferendo pure i giudici.
I suoi 007 potranno adesso richiedere qualsiasi tipo di informazione, intercettare i sudditi in Turchia e all’estero, ottenere dai tribunali documenti riservati. «Ma questa è una violazione dell’articolo 157 del Codice di procedura criminale », commenta scandalizzato il sociologo Dogu Ergil, che con amarezza ricorda: «I servizi segreti del Mit erano il nostro incubo all’università.
Eravamo sotto una sorveglianza continua. Ma a quell’epoca obbedivano ai militari. Oggi, con i cambiamenti proposti, passerebbero agli ordini del primo ministro. Godendo della più completa immunità, oltre quella dei parlamentari. Incredibile».
Il voto amministrativo del 30 marzo prossimo appare così cruciale, e il Partito islamico stringe le fila. Pure il capo dello Stato, Abdullah Gul, sul quale era riposta la fiducia dei moderati, ha disatteso le speranze. Ha avallato le leggi liberticide di Erdogan, prima quelle su Internet, poi quelle sui giudici, e il web lo ha punito. In un lampo, 80 mila persone si sono cancellate dal suo profilo Twitter, cui pure tiene tanto. La rivolta sedata di Piazza Taksim si è trasferita sulla piazza virtuale. È qui, adesso, che si organizza la resistenza. Dice il commentatore Cengiz Candar: «Erdogan e i suoi Sancho Panza hanno
pensato bene di varare una legge su Internet, in grado di bloccare l’accesso a un sito dopo un’eventuale accusa di violazione della privacy. E i provider dovrebbero conservare per due anni tutte le informazioni relative al traffico. Un punto che ricorda “1984” di Orwell». Erdogan come il Grande fratello. La sua «volontà d’acciaio» contro i bit tentacolari di Internet. Chi vincerà in Turchia?
Related Articles
Giorgio Agamben: “Credo nel legame tra filosofia e poesia Ho sempre amato la verità e la parola”
![]()
Gli anni parigini con Italo Calvino, le lezioni di Heidegger e la Roma dei Sessanta. Parla lo studioso che ha saputo spaziare tra estetica e biopolitica
Quei 70 pasdaran del Tea Party che giocano sull’orlo del baratro
![]()
Subito a rischio le spese per pensionati e disoccupati. Senza tagli drastici al welfare, la destra nega i suoi voti all’aumento del tetto al debito. Difficile che i mercati possano essere rassicurati dal piano di Boehner
Rapporto Diritti Globali 2010
![]()
Clicca sulla copertina per visualizzare i materiali disponibili on line del Rapporto sui diritti globali